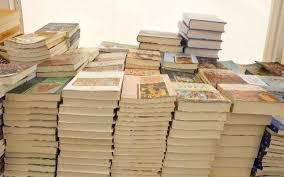*Cass. 4 luglio 2017, n. 16409
1. La sentenza – il negozio di fondazione non richiede l’assistenza dei testimoni
La Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza 4 luglio 2017, n. 16409, affronta la questione se l’atto costitutivo di una Fondazione, che, ai sensi dell’art. 14 c.c., deve rivestire la forma dell’atto pubblico, rientri fra quelli per i quali la L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 48 (nella formulazione vigente ratione temporis, prima quindi della sostituzione operatane dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 12, comma 1) non consenta la facoltà di rinunzia all’assistenza dei testimoni, per la sua assimilabilità, in particolare, ad un atto di donazione. Le conclusioni cui perviene la Suprema Corte, peraltro, sono facilmente adattabili alla disciplina oggi vigente, in cui il citato art. 48, espunte le ipotesi di rinunziabilità ai testi, contempla solo l’alternativa fra atti in cui la loro assistenza è necessaria e atti per i quali l’assistenza dei testi non è richiesta.
Tanto il Tribunale di Macerata, con sentenza 30 gennaio 2008, n. 104, quanto la Corte d’Appello di Ancona con sentenza depositata il 14 aprile 2014, n. 276, avevano, infatti, affermato la nullità dell’atto costitutivo di una fondazione in quanto stipulato in assenza dei testimoni, con conseguente contrasto con l’art. 48 legge notarile, in quanto il negozio di dotazione di una Fondazione ha la medesima natura di un contratto di donazione.
La Suprema Corte ricorda come, in un proprio precedente (Cass. Sez. 2, 8 ottobre 2008, n. 24813, in Riv. not., 2009, p. 679 con nota di BILOTTI, La sorte del testamento conforme a un precedente accordo e l’accettazione dell’eredità da parte della fondazione disposta con lo stesso testamento istitutivo; in Notariato, 2009, 1, 13; in Nuova giur. civ comm.., 2009, 4, 1, 411 nota di LA MARCA, In tema di fondazione costituita per testamento; in Riv. dir. civ., 2009, 6, 2, 737 nota di D’AURIA, Sull’atipicità dell’atto di fondazione istituita per testamento; in Giur. it., 2009, 8-9, 1941; in Fam. Pers. Succ., 2009, 4, 311 nota di GRASSI, Sulla istituzione per testamento di una fondazione), seppur con riferimento ad una Fondazione costituita per testamento, si era già avuto modo di spiegare come la netta bipartizione, operata da parte della dottrina e dalla giurisprudenza più risalente (ad esempio, Cass. Sez. 2, 18 ottobre 1960, n. 2785, in Riv. dir. civ.,1963, II, 172, con nota di GALGANO, Ammissibilità di una fondazione non riconosciuta. Mav., anche Cass., 26 novembre 1960, n. 3141, in Cal. Giur., 1960, 337), tra l’atto di Fondazione, diretto alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, e l’atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, abbia lasciato spazio, nelle elaborazioni successive, ad una diversa ricostruzione del fenomeno, caratterizzata da una sostanziale inscindibilità fra i due momenti.
Ciò ha portato a ricondurre ad unità l’atto di Fondazione, che si compone, attraverso una compenetrazione dei due momenti – quello della volontà di erezione dell’ente e quello dell’attribuzione patrimoniale – dell’atto di costituzione e di quello proprio di Fondazione, in cui trova causa il primo, presentando, peraltro, la caratteristica di dar luogo ad un atto a titolo gratuito.
L’opzione interpretativa della Suprema Corte con la pronuncia n. 24813 del 2008, propende, quindi, per l’unitarietà dell’atto di Fondazione, inteso quale negozio unilaterale mediante il quale il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione, e fornisce i mezzi patrimoniali necessari al conseguimento dello scopo enunciato. Si intende perciò superata la ricostruzione che propende per la distinzione tra atto di Fondazione e atto di dotazione, intesi come negozio principale e negozio accessorio, distinzione che aveva altresì indotto a considerare il trasferimento patrimoniale attuato con l’atto di dotazione come un’istituzione di erede, o un legato, se l’atto di Fondazione sia contenuto in un testamento, ovvero quale donazione, se la Fondazione venga costituita per atto tra vivi.
L’atto di Fondazione è, quindi, ad un tempo, atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia della proprietà di beni che assoggetta ad un vincolo di destinazione allo scopo; nonché atto di organizzazione della struttura preordinata alla realizzazione dello scopo stesso. L’atto enunciativo dello scopo, determinativo della struttura organizzativa ad attributivo dei necessari mezzi patrimoniali, è unico sotto un profilo funzionale, come unico è il conferimento dell’associato rispetto all’adesione al contratto di associazione (essendo questione di fatto, esulante dalle verifiche consentite nel giudizio di legittimità, la dedotta circostanza dell’articolazione procedimentale della fase costitutiva Fondazione in più documenti collegati da relazione di integrazione).
L’atto costitutivo della Fondazione ha, pertanto, sempre la struttura di negozio unilaterale, e non di contratto, rilevando, tuttavia, rispetto ad esso ad substantiam il requisito formale ex art. 14 c.c. L’indispensabilità della solennità del titolo costitutivo (atto pubblico inter vivos o testamento) voluta dal legislatore discende, secondo quanto sostenuto in dottrina, dalla similitudine causale con la donazione, essendo anche il negozio di Fondazione rivolto ad operare un’attribuzione patrimoniale ad un soggetto senza ricevere alcun corrispettivo. Tuttavia, l’effetto della dotazione dell’ente trova la sua autonoma giustificazione causale non nello spirito di liberalità del fondatore, quanto nella destinazione di beni per lo svolgimento, in forma organizzata, dello scopo statutario. L’atto di dotazione trova, cioè, la sua causa nel negozio di Fondazione, rappresentandone un elemento inscindibile ed imprescindibile, né la volontà di destinare i beni allo scopo della Fondazione può distinguersi dalla volontà di creare l’ente. L’atto di attribuzione di beni ad una costituenda Fondazione deve, quindi, considerarsi lo strumento necessario per l’attuazione del fine, perciò inscindibilmente connesso col negozio di Fondazione e privo di una propria autonomia (Cass. Sez. 2, 14 dicembre 1967, n. 2958, in Giust. civ., 1968, I, 864; in Vita not., 1968, 411).
L’unicità dell’atto di Fondazione e dell’atto di dotazione patrimoniale in favore dello stesso, quale componente di un complesso tipo negoziale munito di una propria autonomia causale, e la sua struttura essenzialmente unilaterale, inducono, pertanto, a non ravvisare alcuna automatica traslazione della disciplina in tema di donazione all’atto costitutivo di Fondazione.
Da ciò discende che l’atto pubblico costitutivo di Fondazione, agli effetti dell’art. 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione e perciò non rientra fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, ai sensi della L. 16 dicembre 1913, n. 89, art. 38.
La stessa Cassazione ha chiarito in passato (già prima delle semplificazioni introdotte dalla L. 28 novembre 2005, n. 246) che la presenza dei testimoni non costituisce, in realtà, una formalità coessenziale al tipo “atto pubblico”, tale, cioè, da doversi considerare richiesta per ciò solo che una norma imponga la redazione nella forma dell’atto pubblico notarile. La disciplina generale di questo tipo di veste documentale richiede, piuttosto, che ad essa possa rinunciarsi, trattandosi di formalità disponibile dalle parti, tranne che nelle ipotesi nominativamente indicate nella Legge Notarile, art. 48, comma 1 (Cass. Sez. 3, 4 novembre 1997, n. 10799, in Giust. civ., 1998, I,1369, con nota di VIDIRI, È configurabile un illecito disciplinare del notaio per violazione dell’art. 48, comma 1, l. 16 febbraio 1913 n. 89 nella redazione del verbale di assemblea societaria?; in Vita not., 1998, 1130; in Riv. not., 1998, 939).
La Suprema Corte sancisce, quindi, il principio di diritto in forza del quale «L’atto pubblico costitutivo di una Fondazione, ai sensi dell’art. 14 c.c., non dà luogo ad un atto di donazione, avendo esso struttura di negozio unilaterale ed autonoma causa, consistente nella destinazione di beni per lo svolgimento, in forma organizzata, dello scopo statutario. Ne consegue che l’atto costitutivo di una Fondazione non rientra fra gli atti per i quali è sempre necessaria la presenza di due testimoni, agli effetti della L. 16 dicembre 1913, n. 89, art. 48 (nella formulazione antecedente alla sostituzione operata dalla L. n. 246 del 2005)».
2. La posizione della dottrina
Non constano, invero, specifici precedenti sul punto, se si eccettuano le pronunce di primo grado e d’appello – peraltro inedite – relative alla vicenda all’attenzione della Cassazione.
La questione è stata, tuttavia, affrontata dalla dottrina, che si esprime prevalentemente nel senso della applicabilità dell’art. 48 (nell’ambito della più recente dottrina notarile, FERRERO, sub art. 48, in Boero – Ieva, La legge notarile, Milano, 2014, 319; con specifico riferimento alle fondazioni di partecipazione, BARZELLOTTI, Struttura dell’atto costitutivo, in Fondazione Italiana per il Notariato, Fondazioni di partecipazione, Milano, 2007, 74).
In senso contrario all’applicazione della norma si registrano, infatti, rari interventi, che muovono innanzitutto dal rilievo per cui il negozio di fondazione non è compreso fra quelli per i quali l’assistenza dei testimoni è necessaria (irrinunciabile, secondo la formulazione originaria dell’art. 48, l. not.) e in secondo luogo dalla considerazione per cui la dotazione patrimoniale non è comunque una donazione: l’atto di fondazione, come quello di dotazione, debbono sì avere la forma dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 14, ma non occorre l’intervento necessario dei testimoni salvo che una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere o che una parte o il notaio ne richiedano comunque la presenza («ciò che può in ogni caso prudenzialmente consigliarsi», così CIATTI, Il patrimonio di scopo delle persone giuridiche non lucrative: la fondazione, in Trattato dei contratti, vol. XIX, I contratti di destinazione patrimoniale, a cura di Ciatti e Calvo, Torino, 2014, 444).
Favorevoli alla applicabilità dell’art. 48, l. not., sono coloro che individuano in quello fondazionale una duplicità di negozi fra loro inscindibilmente collegati: l’atto di fondazione in senso stretto, cioè l’atto di organizzazione volto a creare il nuovo centro d’imputazione; e l’atto di dotazione, volto ad apprestare i mezzi patrimoniali sufficienti al nuovo soggetto, che al primo sarebbe ancillare e che, se inter vivos, andrebbe qualificato come donazione (NICOLÒ, Negozio di fondazione e istituzione di erede, in Riv. dir. civ., 1941, 386 ss.; GANGI, Persone fisiche e persone giuridiche, Milano, 1948, 239; RESCIGNO, voce Fondazione (diritto civile), in Enc. dir., Milano, 1968, 801; GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, 10 nt. 211; COSTANZA, Fondazioni e comitati tra pubblico e privato, in Vita not., 1987, 501; BASILE, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Milano, 2003, 105; Cass. 27 febbraio 1997, n. 1806, in Guida dir., 1997, n. 19, 54; BIANCA, Diritto civile, La norma giuridica, I soggetti, 1., Milano, 1978, 317).
A tale tesi, come è noto, si contrappone quella della dottrina per la quale la costituzione della fondazione è una fattispecie unitaria tipica, in cui non è possibile distinguere un atto di fondazione da quello di dotazione, quest’ultimo quindi privo di causa autonoma che lo renda assimilabile alla donazione, dalla quale si distingue anche in punto di disciplina, non essendone richiesta l’accettazione né ammessa la revoca (GALGANO, Delle persone giuridiche, sub art. 11-35, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006, 203 ss.; ID., Diritto civile e commerciale, IV, Padova, 2004, 221; DE GIORGI, Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le fondazioni, in Tratt. Rescigno, 2, I, Torino, 1999, 435; PALAZZO, Testamento ed istituti alternativi, Padova, 2008, 410; PAGLIANTINI, Causa e motivi del regolamento testamentario, Napoli, 2000, 92 ss.; ZOPPINI, Note sulla costituzione della fondazione, in Riv. dir. comm., 1997, 304 ss. Esclude la ricorrenza di una donazione, TAMBURRINO, Persone giuridiche, Associazioni non riconosciute, Comitati, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1997, 194 perché non vede «quale possa essere il soggetto accettante: tale certo non è l’ente che ancora non esiste come persona giuridica»).
Nella prospettiva di chi segue la tesi della duplice natura del negozio fondazionale, quindi, l’atto di dotazione si connoterebbe per la liberalità e sarebbe riconducibile alla donazione, questa sì compresa fra gli atti per i quali, ai sensi dell’art. 48, l. not., l’assistenza dei testimoni è necessaria (per indicazioni bibliografiche sul punto, DEL MEDICO, Sulla necessità dell’intervento dei testimoni nel negozio di fondazione disposto per atto tra vivi, in Riv. not., 1983, 920 ss. Sottolinea l’insidiosità del tema BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993, 272).
In sostanza, la circostanza che il negozio di fondazione racchiuda in sé anche quello di dotazione patrimoniale implica, secondo la dottrina che segue tale ricostruzione, la ricorrenza di un negozio liberale qualificabile come donazione, rispetto al quale quindi ricorrerebbe l’eadem ratio di tutela apprestata, anche sul piano della solennità, dalla legge notarile.
Non va dimenticato che, peraltro, alla medesima conclusione in ordine alla necessità della forma più solenne perviene anche chi rinviene nel negozio di fondazione un negozio tipico di destinazione dei beni per lo svolgimento in forma organizzata di un’attività diretta al perseguimento di uno specifico scopo, qualificabile come negozio unilaterale cui si applica, agli effetti dell’art. 1324, c.c., in quanto compatibile con la sua struttura di negozio unilaterale, la disciplina generale dei contratti (GALGANO, Delle persone giuridiche, sub art. 11-35, cit., 203 ss.). Si afferma, infatti, che quando la fondazione viene disposta per atto fra vivi, la forma solenne non esaurisce la propria ragion d’essere nell’esigenza di eliminare, davanti all’autorità governativa che dovrà provvedere al riconoscimento, ogni dubbio circa l’esistenza e il tenore dell’atto costitutivo, come avviene invece per le associazioni. Vi sarebbe un’ulteriore esigenza, corrispondente a quella che impone la forma dell’atto pubblico per la donazione, di garanzia della spontaneità del volere del disponente e, quindi, al pari di quanto stabilito per la donazione, la forma dell’atto pubblico dovrebbe ritenersi prescritta sotto pena di nullità e dovranno adempiersi le altre rigorose formalità imposte dalla legge notarile per la stipula della donazione (GALGANO, Delle persone giuridiche, sub art. 11-35, cit., 203 ss.).
Tale ultima affermazione non appare, invero, del tutto coerente con la tesi da cui muove: se il negozio di fondazione ha una causa autonoma non sembrerebbe possibile applicare al contempo la disciplina della donazione.
Ed è a tale considerazione che, nella sostanza, sembra rifarsi la sentenza in rassegna che, appunto, aderisce a pieno alla tesi del negozio di fondazione come fattispecie unitaria tipica.
Certo è che la netta prevalenza in dottrina di ricostruzioni che anche solo in via prudenziale, si esprimono a favore della applicabilità dell’art. 48, l. not, spiega il perché, nella prassi, si tenda comunque a richiedere l’assistenza dei testi benché, come si accennava, la norma non lo imponga, riferendosi essa esclusivamente, oltre che agli altri casi previsti per legge, agli atti di donazione, alle convenzioni matrimoniali e alle loro modificazioni, alle dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché al caso in cui anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza, senza, dunque, un riferimento espresso alla fondazione.